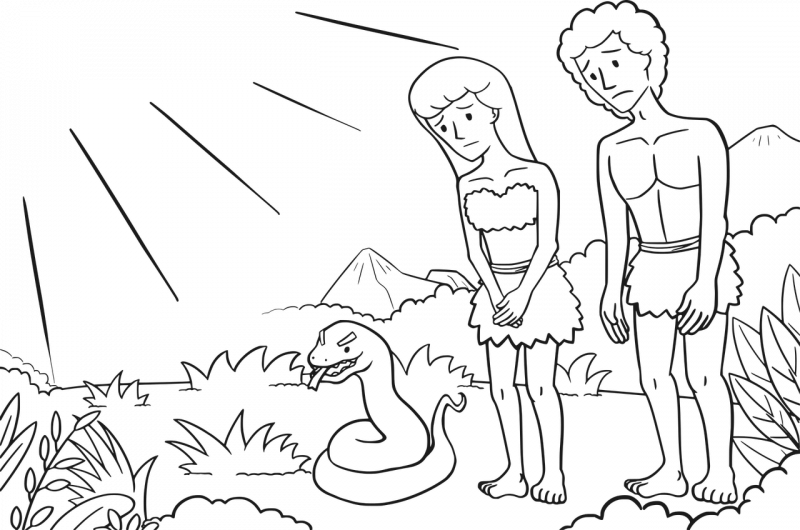La vergogna della vergogna, la viviamo ma non la vogliamo.
Spesso leggo sui social commenti indignati: “Vergogna”, “vergognatevi”.
Possono essere rivolti a persone svariate: spesso ai politici, ma anche a giornalisti, personaggi più o meno famosi o gente comune come noi.
Non è possibile, non si vergognano.
O meglio si vergognano, ma solo per una frazione di secondo: una tensione muscolare, una leggera tachicardia, una mezza vampata di calore, un microsecondo di apnea, mezza goccia di sudore, un leggero afflusso di sangue al volto. Non se ne accorgono nemmeno. Per un decimo di secondo affondano nella loro vergogna. Poi però riemergono e ritornano ad uno stato di grandiosità dissociando la vergogna. I loro volti diventano smorfie di finta serenità.
In Giappone la vergogna è intollerabile, i politici quando sbagliano chiedono scusa pubblicamente e si dimettono, gli imprenditori disonesti si autodenunciano. Ma noi non siamo giapponesi.
Spesso poi si scambia la vergogna per senso di colpa. Noi ci sentiamo in colpa solo quando c’è una sofferenza reale dell’altra persona per una nostra azione o per una nostra omissione.
"Tutto il resto è" vergogna.
Il peccato originale di Adamo ed Eva ad esempio, è un peccato di vergogna per il fatto di essere stati scoperti e non di colpa, non avevano fatto male a nessuno e non avevano procurato nessun danno.
Tra le emozioni cosiddette negative la vergogna ha caratteristiche peculiari. E’ centrale nella nostra organizzazione psichica, anche se storicamente è stata spesso trascurata (Hill, 2015). E’ un’emozione dormiente che, nonostante svolga un ruolo dominante, è difficile da riconoscere e da accettare. Questo vale non solo per i pazienti ma anche per i nostri cari e per noi stessi terapeuti (Lewis, 1987). Ci vediamo sotto lo sguardo di un altro che ci svaluta.
A differenza di altre emozioni come ad esempio la paura, il disprezzo, la rabbia, l’ansia, che determinano reazioni steniche e reattive del corpo, la vergogna (come pure la tristezza) invece, disattiva il nostro organismo, ci butta giù, allo stesso tempo però, gli altri la vedono. Restiamo immobili e senza parole, senza copertura o protezione, siamo impotenti, spacciati, il Sé è svilito nella sua totalità. Vorremo solo nasconderci, scappare o scomparire.
Evoluzionisticamente, la paura, l’ansia o la tristezza in qualche modo ci permettono di chiedere aiuto. L’animale che c’è in noi le manifesta per esprimere all’altro uno stato di disagio che può oscillare da richiesta urgente di aiuto, di cure, di sicurezza o una temporanea necessità di isolamento e ritiro.
La vergogna invece è il contrario di tutto questo, segnala la nostra resa, la nostra inferiorità e la nostra debolezza rispetto a un altro superiore o più forte. Ci mette nei confronti dell’altro in una posizione estremamente svantaggiosa. Non c’è speranza di vicinanza, cura o di cooperazione, l’altro ci vuole offendere, umiliare o schiacciare.
Forse per questo è l’emozione meno tollerabile dall’essere umano, è più vantaggioso chiedere aiuto o affetto piuttosto che mostrarsi o sentirsi inferiori. Succede allora che non la vogliamo, non riusciamo nemmeno a riconoscerla, quando invece ci riusciamo ce ne vergogniamo.
Ci vergogniamo di provare vergogna.
Non riconoscendola, proprio perché è un’emozione “svantaggiosa”, non appena i correlati fisiologici si attivano, la nostra mente la trasforma subito in qualcos’altro: rabbia, disprezzo, in alcuni casi anche ammirazione o idealizzazione dell’altro.
Sono emozioni secondarie, figlie della vergogna, che però ci fanno sentire in qualche modo più forti, più capaci di reagire o più al sicuro.
Tutti noi proviamo vergogna, spesso senza neanche rendercene conto e nelle situazioni più disparate: quando sbagliamo strada, quando la commessa ci chiede “serve aiuto?”, quando becchiamo un condomino nell’androne ed in innumerevoli altre situazioni. Capita che proviamo vergogna anche in situazioni più delicate, più vicine alla nostra vita intima o professionale. Esempi possono essere la classica ansia da prestazione sessuale, la paura che precede un esame o un colloquio di lavoro, il timore di essere giudicati dai nostri amici o familiari se non facciamo tutto nel “modo giusto” e, per noi terapeuti, la paura di non essere abbastanza efficaci coi nostri pazienti. Sono situazioni in cui proviamo paura di vergognarci, paura che se qualcosa va storto poi dovrò prostrarmi, abbassare il capo e alzare le mani. Sono sottomesso, debole, potenzialmente schiacciabile.
Abbiamo quindi paura di vergognarci e poi ci vergogniamo di tutto questo.
Queste sono forme di vergogna moderate, in un certo senso anche normali, se non ci impediscono di raggiungere i nostri obiettivi di vita.
Ci sono altre forme di vergogna per così dire molto più traumatizzanti che sottendono una vera e propria minaccia al Sé. Un genitore violento o estremamente invalidante col figlio, può provocare stati di umiliazione profondi in cui il bambino si sente umiliato fino a vedersi schiacciato, spacciato, non in pericolo di vita, ma profondamente annientato. Da adulto proverà le stesse sensazioni ma dissociandole e manifestandole in forma di spegnimento, rassegnazione alla vita, rabbia, odio e disprezzo nei confronti del vicino di casa che ha la TV troppo alta o verso il partner che lo vuole lasciare. Dietro la rabbia, la paura, la gelosia c’è il terrore bruciante della sconfitta, dell’umiliazione, dell’annichilimento.
Riuscire a riconoscere ed elaborare la vergogna è fondamentale per il nostro sviluppo umano, personale e sociale. Stati moderati di vergogna sono anche necessari sia nel bambino che nell’adulto per favorire una sua maggiore capacità di regolare gli affetti e tollerare le emozioni (Hill, 2015), soprattutto per sviluppare la sana capacità di uscire da stati mentali dolorosi e passare a stati di maggiore benessere (Dimaggio, Popolo, Ottavi, Salvatore, 2019).
UN ESEMPIO CLINICO.
Gina viene in terapia per un profondo stato depressivo, è spenta, ha perso interesse verso qualsiasi attività e verso le relazioni, anche nei confronti di amiche, marito e figli. Ha gli occhi bassi e lo sguardo sfuggente, le spalle tese e le mani giunte al centro delle gambe. Le gambe poggiano sulle punte dei piedi, come un centometrista in posizione di partenza. A me arriva la sensazione che da un momento all’altro possa scappare o lanciarmi un oggetto. In realtà è bloccata, immobilizzata, tesa e rigida. Non potrebbe manco muoversi, non sa se lo vuole ma in ogni caso non ci riesce. Gina fin da piccolissima ha imparato che deve stare al posto suo, se prova a esprimersi o a dire la sua, viene immediatamente giudicata, svalutata o sminuita, peggio ancora ignorata. La madre ha sempre fatto così, la vedeva come una bambina marionetta e non come una figlia dotata di una propria identità e di propri bisogni. Oggi Gina non riesce nemmeno a scegliere cosa indossare, chiede costantemente al marito cosa cucinare, non sa decidere cosa vedere in TV, i figli la chiamano “boomer” perché non sa usare il PC, guida poco e usa male lo smartphone. Ha sempre paura di sbagliare e che i suoi errori siano gravissimi. Eppure ha talento, è laureata, 2 master e un bel lavoro. Ogni decisione per lei è difficile, il timore di una svalutazione, di un giudizio o di una vergogna schiacciante sono sempre presenti.
Riporto questo episodio narrativo che ricostruiamo seguendo gli schemi della TMI (Dimaggio, Popolo, Ottavi, Salvatore, 2019).
Racconta che un giorno il marito, citando Eduardo di “Natale in cassa Cupiello”, le disse che lei non sa fare bene il caffè, da allora non lo fa più, aspetta sempre che lo faccia lui. Eppure il marito scherzava, e lei questo lo sa. Ma il corpo si blocca, il cuore pompa di più, i muscoli si irrigidiscono, il ramo dorso vagale prende il sopravvento e torna a bambina di 4-5 anni, quando la madre la sgridava, esageratamente perché non mangiava, non sistemava i giochi o non riusciva a scrivere le paroline. L’umiliazione e la vergogna sono le stesse di allora. Il tempo, i successi, gli affetti, i risultati umani, sentimentali e professionali raggiunti hanno scalfito di poco il suo modo di stare al mondo. Il suo bisogno fortissimo di riconoscimento e apprezzamento vive sempre nell’aspettativa di essere deluso, che arrivino giudizi, disapprovazioni, facce storte o frasi pungenti ogni volta che prova anche solo a pensare di fare qualcosa. Il rischio di una vergogna annichilente e dell’umiliazione sono presenti a ogni respiro o movimento che fa. Di contro sprofonda in stati di tristezza intensi perché vorrebbe agire ma non può. Viene fuori l’immagine di una che è doppiamente stupida, da un lato perché se agisce già sa che è sbagliata, dall’altro perché non agendo, ai suoi occhi lo diventa. Reagisce a tutto questo con tanti sottili evitamenti che la devitalizzano e la deprimono, altre volte reagisce con atteggiamenti di rabbia immotivata quando nella sua rappresentazione, le sembra che gli altri la stiano svalutando o umiliando (come quando il marito ha fatto la battuta del caffè).
I primi obiettivi della terapia sono quelli di farla uscire dallo stato depressivo, aiutarla a riconoscere tutto questo e come si muove la sua mente. Contemporaneamente, farla sentire al sicuro, con la mia presenza, farle esprimere finalmente il dolore che si porta dentro da sempre, farle vivere l’esperienza che la sua vergogna non è vergognosa, può manifestarla, può farmela vedere, possiamo parlarne e non succede niente. In un secondo momento possiamo poi lavorare piano piano sulle parti sane e rafforzare l’immagine di Sé e la sua identità. Ma questa è un’altra storia.
Dimaggio, G., Ottavi, P., Popolo, R., Salvatore, G. (2019). “Corpo, immaginazione e cambiamento. Terapia metacognitiva interpersonale”. Milano: Raffaello Cortina.
Hill, D. (2017). “Teoria della regolazione affettiva. Un modello clinico”. Milano: Raffaello Cortina.
Lewis, H. B. (1987). “Introduction Shame: The sleeper in psychopathology”. In H. B. Lewis (Ed.), The role of shame in symptom formation (p. 1–28). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.